Una collaborazione di Schermi Magazine e Duemila.Millimetri Sono a casa di una mia amica nella zona nord-est di Roma, su un piccolo balcone quadrato all’ottavo piano. Lei fuma un drummino col filtro alla menta. Sembra la scena di un film mumblecore con Greta Gerwig: dopo una classica cena da fuori sede a base di due fette di pane tostate farcite, una con dei ceci sbattuti con limone e l’altra con gorgonzola e miele, iniziamo a parlare di libri. Racconta di aver regalato per un compleanno una rara edizione di Amori giovanili di Goethe, che è riuscita a trovare usata a solo un euro e cinquanta. Poi mi chiede se leggo tutti i giorni visto che le parlo spesso di libri che mi piacciono. (Ovviamente no). Spiego che provo a ritagliarmi degli spazi dove leggo e basta, come una meditazione. Ho sempre trovato semplice concentrarmi su qualcosa per lungo tempo, ma tendo anche ad ossessionarmi facilmente. Una declinazione di un’addictive personality, ipotizzo. Lei invece dice di essere l’opposto: appena inizia una cosa la lascia a metà, per farne un’altra. Ha provato anche un test online per il disturbo dell’attenzione, ma mai nulla di attendibile. Le dico che per me la concentrazione è come un muscolo, che deve costantemente essere allenato. Che falso. Per quanto la conversazione sia realmente accaduta, è in verità da qualche mese che non riesco a vedere un film dall’inizio alla fine in una sola volta. Qualche anno fa non mi capitava, riuscivo a fare sessioni anche da tre film di fila. Oggi invece finisce sempre che non ho tempo per terminare la visione o che mi addormento (succede sempre se il film mi piace, non so il perché). O trovo troppo faticoso dover scegliere tra infinite possibilità. Mi sembra un sentimento ormai comune alla nostra generazione (e non solo): l’ADHD e la FOMO, la difficoltà nel concentrarsi su qualcosa per più di quindici secondi o fino a quando ci viene in mente che dovevamo fare quell’altra cosa, rispondere al messaggio di quella persona. L’Attention Span medio odierno è di circa 8 secondi. È troppo facile però dare la colpa alla tecnologia. Il problema si trova piuttosto nel modo in cui la nostra attenzione è stata monetizzata. Senza entrare in tecnicismi: più tempo passiamo su una piattaforma, più questa guadagna. E allora la guerra si fa feroce, un tutti contro tutti. Oggi ogni cosa è Contenuto, i film non combattono più con altri film, né i libri con i libri. Questo succedeva già con la TV ma quello che cambia davvero oggi è la simultaneità e l’onnipresenza. Posso ascoltare un disco, mentre scrollo su instagram e al contempo guardare un film nell'angolinodello schermo, leggendo i sottotitoli. A volte l’ansia della possibilità di tutte queste opzioni è paralizzante. Secondo alcuni, in realtà non è vero che la nostra capacità di concentrazione è diminuita ma è invece aumentata quella del nostro cervello nel selezionare su cosa concentrarsi. Ma credo anche che questa nuova capacità non sia ancora abbastanza sviluppata. Nel 2003, in una video-intervista ad una televisione tedesca David Foster Wallace parla esattamente di questo nuovo stato dell’essere post-moderno. Una costante e insaziabile ricerca del piacere attraverso i media - nel suo caso parla della televisione ma la stesso vale per i social - che ci rende impossibile concentrarci su una cosa sola per più di una manciata di secondi. Dice che lui non può avere una televisione dentro casa, altrimenti la guarderebbe tutto il giorno. In pratica descrive lo scrolling: essere convinti, nel retro della propria mente, che ci sia sempre qualcosa di più interessante sul prossimo canale. Ho ripensato molto a questa frase: «C’è un’altra parte di te che sente la necessità di silenzio e tranquillità, e di poter pensare alla stessa cosa per magari mezz’ora invece che trenta secondi, ma che non viene mai sfamata». Tutta questa introduzione serve per arrivare a una domanda: ma quindi se questo è lo stato delle cose, che senso ha la critica oggi? Che senso abbiamo noi che guardiamo i film? Serviamo solo a comprarli? Interessa ancora a qualcuno quello che abbiamo da dire? La critica cinematografica oggi si può dividere perlopiù in due categorie: la prima è un’appendice del reparto marketing, che è pagata per promuovere il film indirettamente, per parlarne bene anche se in realtà non è piaciuto. La seconda è simile a una scena di Caro Diario, in cui Nanni Moretti legge ad un ad un critico allettato le sue stesse recensioni verbose e prive di senso. Una non esclude l’altra in ogni caso, anzi, di solito sono fuse insieme. Prima non era così. Il cinema era di tutti, oggi di pochi. Combatte per una fetta di mercato sempre più piccola, per attirare l'attenzione di sempre meno persone, e lo spettatore pensa di non aver più alcun valore tranne quello economico. Il cinema riflette la società, quella di oggi è distratta e frammentata. E allora anche chi parla di cinema lo diventa inevitabilmente. Pubblica recensioni-reel di un minuto in cui è capace di dire solo è bello, girandoci intorno con qualche supercazzola. Sento in me stesso e nelle persone con cui parlo, la necessità di tornare a dedicare più tempo a poche cose selezionate. Qualcosa che è faticoso da mettere in pratica per la bulimia di prodotti che abbiamo a disposizione, ma uno sforzo necessario se ci vogliamo riappropriare della nostra attenzione. Per quanto essere spettatore oggi possa apparire più facile, data la semplicità con cui possiamo vedere un film, in realtà è più difficile del passato. Perché non tutti i prodotti valgono la pena di essere visti e siamo noi che dobbiamo adattarci per diventare fruitori attivi, selettivi, attenti, a quello che guardiamo, leggiamo e ascoltiamo. La nostra soluzione, che ci è concessa anche grazie alla tecnologia, è prendere la via del DIY. Provare nel nostro piccolo a creare una comunità di amanti di cinema che cercano qualcosa di più di un tik tok da consumare rapidamente, mentre stanno sul cesso, tra un video di gatti e uno di cucina. Il mio spazio è finito, rompo ancora una volta la quarta parete per lasciare la penna a Eleonora, una delle fondatrici di Schermi Magazine e, da un po’ di tempo, cara amica. Salto temporale, dalla buia cameretta di Niccolò ci troviamo ora in un ambiente diverso: il bar della Sapienza in piazzale Aldo Moro. L’ateneo più grande d’Europa ci offre solo due sedie scomode e un tavolino sporco per intraprendere la nostra discussione sul ruolo della critica cinematografica negli ultimi anni. Cerchiamo di spiegare il motivo per cui nasce questa collaborazione tra le nostre riviste, Schermi Magazine e Duemila.Millimetri, attraverso questa sorta di Manifesto. In realtà tracciare un percorso lineare per chiarire le dinamiche di quest’incontro non è facile. Negli ultimi mesi ci siamo scritti e abbiamo parlato a lungo, senza alcuna pretesa, delle nostre percezioni rispetto al mondo cinematografico odierno, la sua struttura e le sue infinite diramazioni. Ogni discussione, inconsciamente, segnava una nuova tappa del percorso, che per la prima volta oggi assume una forma più o meno stabile, quantomeno concreta, in questa fanzine. Il ruolo del giornalismo cinematografico, lo spazio che dovrebbe occupare, l’inevitabile confronto con il web e la digitalizzazione all’interno della nostra quotidianità, erano i macrotemi che costituivano la base delle nostre chiacchierate e in modo sempre più preponderante tornavano verso di noi. Crediamo che questo possa essere il primo passo per dare una direzione più ordinata ai contenuti di cui si accennava in precedenza. E siamo qui oggi ad elaborare il numero 0 della nostra prima collaborazione, per provare a sviscerare e analizzare l’evoluzione della critica cinematografica e il suo adattamento all’interno del nuovo panorama digitale, con lo sguardo di due riviste indipendenti gestite da ventenni. La domanda è: il giornalismo cinematografico può ancora godere di uno spazio? Può una recensione di un minuto su Quarto Potere approfondire il mondo immenso che quella pellicola rappresenta nell’universo cinematografico e non solo? Ci piace credere che ovviare a una crisi simile possa essere ancora possibile, ma per farlo occorre prima individuare le carenze del sistema sopracitato. È chiaro che questa non vuole essere una lezione attenta e dettagliata, cronologicamente strutturata, sul ruolo della critica cinematografica e sulla crisi che attraversa da alcuni decenni - anche perché non è questo ciò che ci interessa. La nostra esigenza prende vita, in realtà, da un discorso estremamente elementare e molto più semplice: capire perché di cinema si parli poco, e perché le poche volte che si prova a intavolare una discussione sul tema non sempre quel che ne esce fuori risulta consono, secondo noi, rispetto al linguaggio cinematografico e le strutture che lo compongono. È ormai chiaro che, con il rapido sviluppo della tecnologia e i processi di digitalizzazione, le logiche dell’industria culturale abbiano subìto una radicale trasformazione, e questo vale indubbiamente anche per il mondo del cinema: in questo marasma di stimoli, il marketing e il linguaggio artistico tendono a confondersi facilmente. Chiaramente comprendiamo le modalità di adattamento che chi parla di cinema oggi ha dovuto adottare, ma quello che vediamo e leggiamo non sempre ci rappresenta e non ci soddisfa come amanti della settima arte. Il più delle volte il racconto del film attraverso la foryou page dei nostri social sovrasta il racconto interno del film che abbiamo visto in sala - ammesso abbiate ancora il coraggio di entrare in quel luogo desertico e spettrale. È in questo caos, prepotente e indomabile, che vogliamo inserire questa riflessione: i social media sono oggigiorno l’unico contenitore a consentire una divulgazione sostenibile e a permettere un grande coinvolgimento volto a formare lo spettatore odierno, ma soprattutto ad avvicinare quello di domani. Il codice comunicativo è cambiato, e l’unica possibilità che abbiamo è quella di adattarci a questa trasformazione, ma con il dovere morale di gestirla adeguatamente, di imparare a controllarla, e soprattutto cercando di evitare che la pellicola trattata venga ridotta a un frugale giudizio di gusto personale. Provando ad allontanarsi quanto più possibile dalla superficialità del verdetto arbitrario che divide il film in bello/brutto. La nostra proposta concreta è creare degli articoli d'approfondimento, cercando di rapportare l’opera con l’universo culturale e visivo contemporaneo ma al contempo snaturarla il meno possibile dal contesto d’appartenenza. Se vorrete, ci ritroveremo in questo spazio metafisico, aperto e indipendente, una volta ogni due mesi per approfondire - ognuno con la propria prospettiva e autonomia - il mondo cinematografico e i soggetti che lo abitano.
di Eleonora Verardi e Niccolò Della Seta Issaa
SOCIAL
© Schermi Magazine
Una critica da brainrot - Parlare di cinema nell’era digitale
Una critica da brainrot - Parlare di cinema nell’era digitale
2025-01-16 11:38
2025-01-16 11:38
author
author //www.schermimagazine.com/favicon.png
Articoli,
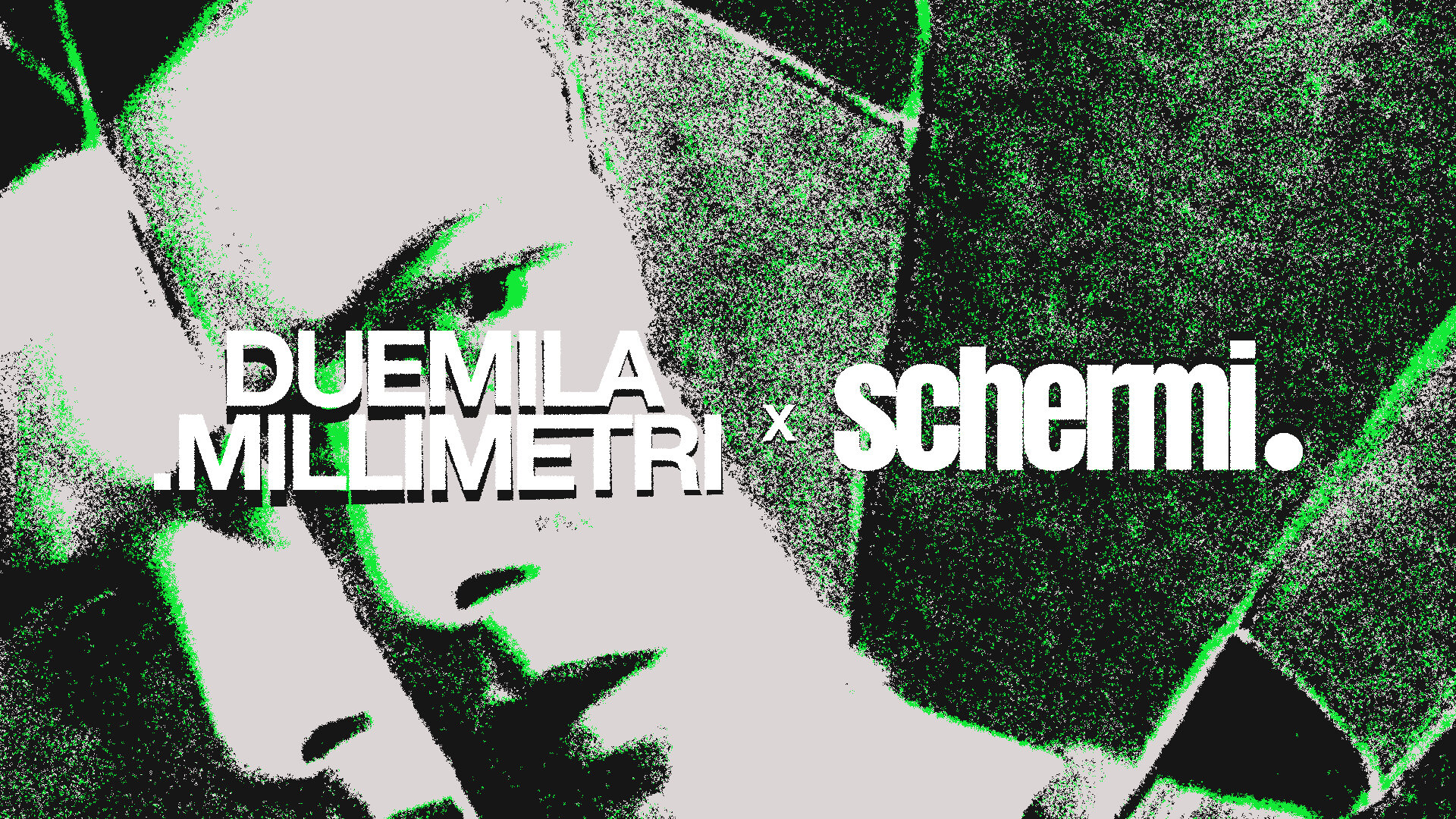
Una collaborazione di Schermi Magazine e Duemila.Millimetri
CONTATTACI
SOCIAL
Italia
© Schermi Magazine